
L'astronave del Rinascimento, storia della Rotonda della Besana
— Nino Sambataro
Anche gli automobilisti più distratti non avranno potuto fare a meno di notare almeno una volta, passando per le vie semicentrali della nostra città, lo strano edificio di mattoni a vista, noto come Rotonda della Besana, che sta lì, non si sa bene a fare cosa, da qualche secolo a questa parte. Se sapessero il suo antico nome, “Foppone dell’Ospedale Maggiore”, o meglio, se qualcuno gliene svelasse il significato, di colpo questa specie di astronave rinascimentale assumerebbe un senso del tutto nuovo.
La denominazione “Foppone dell'Ospedale Maggiore” deriva dalla voce milanese “foppa”, che significa ”fossa”. Questo termine era utilizzato per indicare i numerosi cimiteri presenti a Milano. Quindi, la Rotonda della Besana era conosciuta come “Foppone dell'Ospedale Maggiore” (letteralmente: grande fossa), proprio perché originariamente fungeva da cimitero coperto per la Ca’ Granda (l'attuale Policlinico di Milano).
Oggi non si nota più, ma a sul finire del Seicento l’Ospedale e il Cimitero erano collegati da una via rettilinea – l’odierna via San Barnaba – per mezzo di un ponte che attraversava il Naviglio (oggi interrato sotto via Francesco Sforza). Un segno tangibile di questa opera è ancora oggi visibile nella Porta della Meraviglia, sul retro della Ca' Granda.
Non che prima del Seicento l’Ospedale fosse sprovvisto di un camposanto. Si moriva anche prima. Infatti, fin dalla sua fondazione, nel 1456, la Ca’ Granda disponeva di un cimitero coperto situato lungo il Naviglio e conosciuto come “La brugna”. Tuttavia, alla fine del Seicento i rappresentanti dell'Ospedale si trovavano a dover fronteggiare continue lamentele da parte degli abitanti della zona, a causa degli odori insopportabili che si diffondevano nell'ambiente circostante al camposanto. Non potendone più delle lamentele, i venerabili consiglieri dell'Ospedale presero la decisione di acquisire un nuovo terreno situato fra la chiesa di Santa Maria della Pace e i bastioni spagnoli. Nella zona dove c’è oggi la Rotonda, appunto.
Nel 1695 ebbe così inizio la costruzione - sotto la direzione dell’ingegnere collegiato dell’Ospedale Arrisio Arrigoni - di un sepolcro coperto, con annesso oratorio, accuratamente separato dalle abitazioni dei bravi cittadini. La costruzione del nuovo cimitero fu completata nel 1697 e le prime inumazioni avvennero nel luglio dello stesso anno. Nel 1700 si pianificò anche la trasformazione dell'oratorio in una chiesa: una volta raccolti i fondi necessari, la nuova costruzione ebbe inizio nel 1719, con il titolo di San Michele Arcangelo ai Nuovi Sepolcri.
Tutto è bene quel che finisce bene? Macché! Con l'elevazione della chiesa, l'acqua cominciò a infiltrarsi nei sepolcri emanando un odore sgradevole; inoltre, ci si rese conto che il numero dei defunti superava la capacità dei sepolcri. Per porre rimedio a questa situazione, nel 1719 iniziò la costruzione del grande porticato attorno alla nuova chiesa, con l'intento di ospitare ulteriori sepolcri. Il porticato fu completato nel 1731, grazie al generoso sostegno finanziario del ricco mercante di sete Giambattista Annone. Furono quindi progettate nuove sepolture più elevate dal suolo, per evitare l'inondazione da parte delle sorgenti d'acqua.
Per nostra fortuna sono poi arrivati gli austriaci, che hanno emanato una serie di editti a favore della salubrità dell’aria. Ci fossero ancora loro, a Milano avremmo un’aria più fina. Infatti, dopo il 1792 l'edificio subì la dismissione in risposta alle disposizioni della legislazione sanitaria austriaca, che chiedeva lo spostamento dei cimiteri al di fuori della cerchia cittadina.
Napoleone pensava ancora più in grande e durante il suo tempo, l'architetto Luigi Cagnola concepì un progetto ambizioso per trasformare il complesso in un pantheon del Regno Italico, di cui Milano era la capitale. Tuttavia, con la caduta dell’Imperatore e la riannessione all'Austria, non se ne fece più niente.
Successivamente l'edificio ha sperimentato varie trasformazioni, fungendo a turno da caserma, fienile, cronicario e lavanderia dell'Ospedale, fino al 1940. Dal 1958 il complesso è di proprietà comunale e ha assunto una nuova vita come spazio pubblico, oltre che come luogo espositivo per mostre temporanee, proiezioni ed eventi culturali.
Insomma, il Foppone dell'Ospedale Maggiore, ribattezzato con eleganza “Rotonda della Besana”, è un campione di adattamento tra gli edifici cittadini. Da “grande fossa” della Ca’ Granda a potenziale pantheon napoleonico, passando per inondazioni e odori sgradevoli, questa astronave rinascimentale ha navigato attraverso secoli di cambiamenti.
Oggi, dopo aver servito come caserma, fienile e lavanderia (senza dimenticare la breve parentesi cronicaria), la Rotonda si è ritrovata a essere la casa del Museo dei Bambini di Milano (MUBA). In fondo, anche gli edifici hanno il loro modo ironico di reinventarsi, dimostrando che nella città di Milano, persino le rotte più strane possono portare a un nuovo e interessante destino.
Da camposanto a campus
La Rotonda della Besana ospita periodicamente anche i campus estivi e natalizi del Policlinico di Milano. Grazie alla collaborazione con il Museo dei Bambini (MUBA), i figli dei suoi dipendenti possono vivere delle esperienze stimolanti nei giorni in cui le scuole sono chiuse, con percorsi dedicati al riciclo dei materiali e alla creatività. Tutte le giornate sono state sempre sold out, e sono inserite a pieno titolo nel welfare aziendale che il Policlinico ogni anno mette a disposizione dei suoi collaboratori e delle loro famiglie.
Articolo tratto dal magazine Blister, storie dal Policlinico per curare l'attesa.
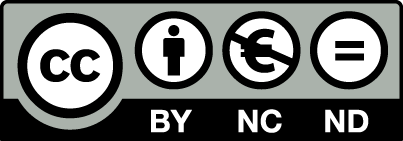
 News e consigli dagli esperti
News e consigli dagli esperti