
Contribuire a un futuro migliore. Intervista a Daniele Dondossola
— di Ilaria Coro
Nella vita, come in campo, può fare la differenza il gioco di squadra, in cui ognuno ha un ruolo ben preciso: il difensore non può essere anche attaccante e il terzino non fa il portiere. Riconoscere negli altri specifici talenti e particolarità come ricchezze consente di raggiungere tutti insieme traguardi importanti.
Uno “spirito di gruppo” che caratterizza alcune vite, diventando un elemento comune a lavoro, interessi e passioni. Come nel caso di Daniele Dondossola, specialista della Chirurgia Generale - Trapianti di Fegato del Policlinico di Milano e ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, che ha sempre considerato il lavoro di équipe un punto di forza fondamentale per contribuire a dare un nuovo futuro ai pazienti con malattie del fegato in stadio avanzato e per migliorare sempre di più le tecniche in grado di aumentare la vita degli organi da trapiantare.
Anche in medicina il gioco di squadra fa la differenza?
Nell’ambito della chirurgia è un aspetto fondamentale, che mi ha subito colpito di questa disciplina. Ho scelto la strada della chirurgia dei trapianti di fegato sia per il rapporto con il paziente, che non finisce quando viene dimesso ma continua con i controlli chirurgici nei 3 mesi successivi all’intervento, ma anche perché non si è mai da soli a decidere il suo percorso pre e post trapianto. Entrano in campo expertise molto diverse. In primis, c’è sempre un confronto con gli altri colleghi del reparto e poi con molte altre équipe: epatologi, radiologi, endoscopisti, gastroenterologi, anestesisti, rianimatori, psicologi, assistenti sociali. Questo è anche poi il modo con cui concepisco la ricerca, che deve essere sempre il più possibile multidisciplinare.
Di solito la ricerca si associa al laboratorio e non alla sala operatoria.
Storicamente il nostro gruppo si è concentrato soprattutto sulla ricerca di nuove tecniche in grado di migliorare le condizioni del fegato prima dell'intervento così da aumentare il numero e la qualità degli organi disponibili per il trapianto. Con un modello preclinico riproduciamo una metodica che viene già usata durante i trapianti, chiamata “Machine Perfusion”, per ottimizzarla e trattare al meglio un fegato dopo che viene prelevato dal donatore e prima che l’organo sia impiantato nel paziente ricevente. Un’attività scientifica che nei decenni si è concretizzata con un grande beneficio per i pazienti soprattutto se consideriamo che nel 2023 metà dei nostri pazienti trapiantati senza le macchine da perfusione non avrebbero potuto ricevere un fegato o comunque sarebbero andati incontro più facilmente a varie complicanze. Siamo tra i pochi gruppi di ricerca che lo fanno a livello nazionale ed europeo.
Ritorna il concetto di “gruppo”.
Esatto. La ricerca biologica ti pone delle sfide importanti e ti impone di affidarti agli altri ricercatori, perché bisogna ammettere di non saper fare tutto e riconoscere le expertise di ognuno.
Parlo di gruppo perché anche in questo caso senza il team che si occupa di Ricerca Preclinica, i ricercatori della Biobanca, gli anestesisti, i rianimatori, gli epatologi, non potremmo fare ricerca e viceversa noi aiutiamo loro fornendo le cellule epatiche da cui partono per sviluppare nuovi modelli preclinici in laboratorio, come organoidi e colture cellulari.
Quello che mi affascina della ricerca preclinica è che permette di non mentire mai. I risultati che si ottengono sono più oggettivi e hanno una sola interpretazione mentre in altri ambiti della ricerca, anche se involontariamente, le spiegazioni che diamo ai risultati sono più soggettive. L’attività preclinica ti permette di ampliare la mente, di scoprire e di portare poi le innovazioni anche in clinica.
Chirurgo, ricercatore ma non solo. Ha partecipato a diversi progetti umanitari internazionali, in scenari persino di guerra. Cosa la spinge a partire ogni volta?
Come medico, c’è sempre la volontà di riuscire a garantire cure adeguate anche nei luoghi più disastrati del mondo, associata però alla voglia un po’ “egoistica” di scoprire, di darsi delle risposte vivendo direttamente quelle realtà piuttosto che conoscerle attraverso i media. Sono stati diversi i progetti a cui ho partecipato e, piano piano, sempre più “complicate”, partendo da piccoli progetti: dalla raccolta fondi per costruire pozzi d'acqua e fare formazione in Mali, allo sviluppo di una rete di medicina sociale in alcuni villaggi del Kosovo, dove facevamo medicina di base e portavamo medicine, fino alla collaborazione con Ong Rainbow for Africa che ha permesso di portare aiuti in Ucraina all'inizio del conflitto e di fornire cure oncologiche avanzate ai pazienti residenti nella Striscia di Gaza. L’elemento comune a tutti è cercare di scoprire il territorio per fornire i mezzi in grado di rispondere alle esigenze e rendere autonomo chi vive in quelle zone.
Un episodio che le è rimasto impresso?
Un momento che ricorderò sempre è stato un incontro che ho avuto alla frontiera in Ucraina, tra i militari delle due nazioni, all'inizio del conflitto con un cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico di Kiev. Attimi di tensione ma anche sguardi riconoscenti per aver ascoltato i bisogni di un territorio che in quel momento era stravolto da un evento acuto che come la guerra. All’uscita dall’Ucraina le code erano gigantesche ma i nostri passaporti ci hanno permesso di passare le frontiere rapidamente senza difficoltà. Un progetto che ha consentito di portare in salvo in Italia un piccolo di sei mesi, nato con una grave malformazione intestinale e urologica, insieme alla sua mamma. Al Policlinico di Milano ha effettuato diversi interventi chirurgici ricostruttivi e dopo sei mesi il bimbo e la sua mamma sono potuti ritornare a casa.
Articolo tratto dal magazine Blister, storie dal Policlinico per curare l'attesa
Chirurgia Generale - Trapianti di Fegato: la Ricerca in Policlinico
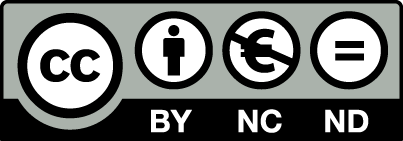
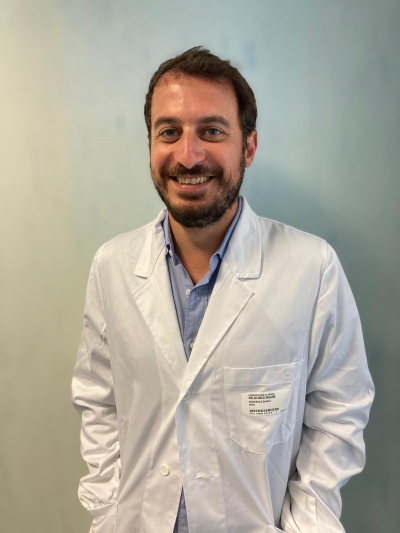

 News e consigli dagli esperti
News e consigli dagli esperti